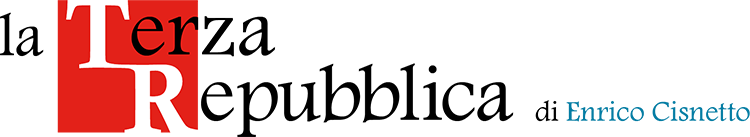Dall'Europa un favore a Putin
DAL VERTICE UE CHE LASCIA L’EUROPA DIVISA AL CASO VANNACCI, PUTIN GONGOLA (PER GLI ERRORI DI MELONI)
di Enrico Cisnetto - 14 febbraio 2026
Per quanto possa sembrare paradossale, c’è un filo rosso che lega il vertice europeo che si è svolto giovedì in Belgio, importante ma per molti versi deludente, e l’esordio di Futuro Nazionale, il partito (si fa per dire) dell’ineffabile generale Vannacci. E su quel filo c’è raffigurata l’effige di Vladimir Putin. Eh sì, perché l’autocrate del Cremlino è, nello stesso tempo, colui che ha più da guadagnare dall’esito inadeguato del summit continentale, e quello che ha tessuto la tela della strana, ma non casuale, incursione nella politica italiana dell’ennesimo soggetto anti-europeo. E in entrambi i casi, Putin non ha che da ringraziare Giorgia Meloni, autrice di un doppio errore politico da matita blu. Ma andiamo con ordine.
La riunione dei leader europei nel castello medievale (scelta incongrua per chi dice di volersi proiettare nel futuro) di Alden Biesen non ha preso decisioni, né doveva prenderne visto il suo carattere informale. Doveva però servire a due cose: misurare il grado di consapevolezza del momento epocale che l’Europa vive e definire un percorso attraverso il quale articolare la propria risposta allo stravolgimento dell’ordine internazionale che la vede subire, contemporaneamente, la fine di un’alleanza storica (Usa), la presenza minacciante di un nemico alle porte (Russia) e l’incombenza sui mercati di un concorrente tanto spietato quanto sempre più qualificato (Cina). Diciamo che la coscienza del rischio che l’Ue possa crollare come il muro di Berlino nel 1989 era presente, ma non fino al punto da soddisfare la seconda, fondamentale esigenza. Infatti, i leader continentali, invece di considerare come prioritaria la questione della sicurezza, come due pericoli incombenti avrebbero dovuto indurli a fare – la sempre più incerta tenuta dell’Ucraina di fronte alla pressione russa e allo smarcamento americano, e il progressivo stravolgimento della Nato per mano di Trump (vedi la minaccia alla Groenlandia, che sarebbe un errore considerare del tutto rientrata), che richiede la costruzione di una realtà tutta europea della difesa – si sono concentrati sulla decrescente competitività del Vecchio Continente. Tema centrale, per carità, oggetto dei report, ormai di due anni fa, di Mario Draghi ed Enrico Letta – entrambi presenti all’incontro per ribadire che le loro indicazioni sono state tanto applaudite quanto ignorate – ma a mio avviso non così cogente come la risposta alla domanda “qual è e quale deve essere il posto dell’Europa nel mondo delle grandi potenze che hanno sostituito alla forza del diritto il diritto alla forza?”. Certo, non c’è solo la forza militare, anche quelle industriale, finanziaria, tecnologica, commerciale contribuiscono a determinare il peso specifico di una potenza. Ma nella geopolitica andata in tilt, la capacità autonoma di difesa viene al primo posto.
Peraltro, sulla competitività nel castello delle Fiandre si sono scontrate due ricette contrapposte, senza però domandarsi come mai finora sia stato fatto poco o nulla per fronteggiare questo declino. Una è quella francese, l’altra è quella tedesca (su cui Meloni ha lestamente messo il cappello sopra, per ragioni solo politiche, sottovalutando le controindicazioni che ci sarebbero per l’Italia se fosse adottata). La prima ha connotati che gli oppositori definiscono “dirigistici”: estensione massima della clausola di “preferenza europea”, che vincola pubblico e privato a privilegiare prodotti e servizi “made in Ue”, e ricorso al debito comune per finanziare gli investimenti e la ricerca. La seconda viene liquidata come “liberista”: semplificazione e deregolamentazione di molte normative europee, a cominciare da quelle ambientali (smontare il “Green Deal”) per ridurre i costi di produzione, e sovranità nazionale in materia di spesa pubblica (no agli eurobond). Inutile dire che entrambe le ricette sono egoistiche – cioè riflettono gli interessi politici ed economici di Parigi e Berlino, figli di differenze strutturali di antica data dell’asse franco-tedesco – e che siccome ciascuna presenta pro e contro, la vera questione sarà trovare il necessario compromesso, il cui dosaggio dipenderà dalla quantità e dal peso dei paesi che si schiereranno sull’uno o sull’altro fronte. Macron ha con sé Sanchez e i paesi scandinavi, mentre Merz ha scelto Meloni, che si è inventata l’inesistente “motore italo-tedesco” (le due economie sono sì legate, ma il loro modello di sviluppo è in entrambi i casi in crisi irreversibile) senza capire che la capacità di indebitarsi dei due paesi è così sideralmente diversa che il vantaggio sarebbe tutto tedesco, a discapito del nostro made in Italy. Inoltre, è evidente il motivo per cui il cancelliere tedesco sta “usando” la presidente del Consiglio: essendo Meloni la leader europea pervicacemente più vicina a Trump – l’ultima conferma viene dalla notizia che Vance ha scritto la prefazione per l’edizione americana del suo libro, "Giorgia's Vision”, sulla cui copertina campeggia una citazione del presidente americano “[Meloni è] uno dei veri leader del mondo” (come se i fischi di San Siro al vicepresidente Usa non li avesse sentiti) – gli serve per tenere aperto un canale informale di comunicazione con la Casa Bianca, nell’idea, invero peregrina, di poter così meglio fronteggiare la concorrenza di Afd.
Ma al di là delle ricette diverse, il nocciolo della questione sta nel fatto che non è un caso che finora la Ue abbia lasciato lettera morta i suggerimenti di Draghi e Letta. Perché l’unico modo per farlo è arrivare ad una maggiore integrazione politico-istituzionale. E per soddisfare questa pre-condizione, occorre prioritariamente affrontare il tema della governance comunitaria. Cosa che in Belgio non si è fatta. Né nell’ambito dei 27, sapendo che persiste il diritto di veto, né cercando di aggregare i paesi che credono nell’Europa federale. Sì, è stata evocata la “cooperazione rafforzata” – la modalità con cui, per esempio, fu avviato il processo di costruzione dell’euro – ma nessuno ha colto il messaggio che Draghi ha voluto lanciare nel suo intervento a proposito del “federalismo pragmatico” da lui propugnato: “se non delegate a uno che decida per tutti, non funzionerà” (più chiaro di così, considerata la sua misurata prudenza, l’ex governatore della Bce non poteva essere). Invece, la forzatura italo-tedesca è servita a riproporre l’Europa delle intese bilaterali, anziché a “due velocità”. In cui il gruppo di paesi che va più veloce verso l’integrazione delinea un’Europa più ristretta ma più compatta e quindi politicamente più forte, e come tale aperta ad interlocuzioni con paesi extra Ue come Canada, Gran Bretagna, Norvegia, Giappone e Australia, ovvero i membri di quella “Alleanza Occidentale” (così mi piace chiamarla) già sperimentata dalle riunioni dei Volenterosi, capace di tener testa agli Stati Uniti di Trump e alle autocrazie globali.
Ecco perché mi immagino Putin compiacersi delle notizie che gli arrivavano dal vertice europeo, da cui ha potuto trarre conforto che le sue mire di disarticolare un continente dieci volte più ricco della sua Russia possono realizzarsi, con la implicita complicità di Trump. Così come me lo immagino sghignazzare per il buon esito di un nuovo capitolo della sua guerra ibrida in terra italiana, la nascita e l’affacciarsi sulla scena del partito di Vannacci, al cui esordio ha centrato un doppio obiettivo: ha sommato il no al rinnovo degli aiuti all’Ucraina dei suoi parlamentari (solo tre, ma hanno lasciato il segno) a quello dei 5stelle e dei “sinistrati” di Avs contro – naturalmente in nome della pace, mica per fare un piacere alla Russia, ci mancherebbe altro – e nello stesso tempo ha votato la fiducia al governo, di fatto facendo ingresso nella maggioranza che lo sostiene, creando non pochi imbarazzi.
Ora, anch’io come il mio amico Follini – che sull’argomento ha scritto su La Stampa del 6 febbraio un articolo magistrale – sono convinto che Vannacci sia un “fascista da operetta” specchio in cui si riflette la pochezza altrui, e per questo destinato ad essere un “fiammifero che si spegnerà prima di far danno”. Ma concordo con Tremonti, che ha definito il generale ex salviniano “De Gaulle alla Scilipoti”, quando nel domandarsi chi ha scritto il libro “Il mondo al contrario” che lo ha portato alla ribalta, si risponde che con tutta evidenza “ogni capitolo ha un mano diversa, uno stile diverso”, il che significa che è “un prodotto assemblato” per mano “dei russi”. E proprio per questo non ne sottovaluto l’uso strumentale che ne può fare chi lo eterodirige. Per esempio, se fossi un funzionario del Cremlino o del SVR, il servizio di intelligence estera (erede del Kgb, dove Putin si è fatto le ossa), sarei estremamente soddisfatto di almeno tre cose: che qualcuno faccia fino in fondo quello che Salvini ha solo evocato a parole, senza dare seguito concreto perché ha anteposto l’obiettivo di tutelare il potere che gli deriva dallo stare al governo (la Lega ha sempre finito per votare gli aiuti a Zelensky, non farlo avrebbe significato uscire dalla maggioranza); che nel parlamento italiano si sia formata un’alleanza trasversale destra-sinistra contro Kiev; che la nuova formazione sponsorizzata da Mosca si sia incuneata nel centro-destra, conquistando una qualche possibilità di destabilizzazione.
Tutto questo, l’impasse europeo e la vicenda Vannacci, si devono agli errori di Meloni, che pure è sicuramente e sinceramente schierata contro Putin. Ma nel primo caso, il persistere del suo vecchio anti-europeismo – subordinato a ragioni tattiche ma non soffocato, almeno non del tutto – ma ancor più la pervicace convinzione di avere da guadagnare nell’alimentare l’amicizia con Trump, l’hanno spinta a far comunella con Merz, che rispetto a lei si mantiene furbescamente diversi passi indietro rispetto alla linea dell’abbraccio a The Donald, senza capire che il primo a guadagnarci se non nascono gli Stati Uniti d’Europa è proprio l’autocrate del Cremlino. Nel secondo caso, il tappeto rosso all’incedere di Vannacci l’ha steso la presidente del Consiglio quando si è intestardita a voler mettere il voto di fiducia sulla norma pro-Kiev, probabilmente per l’ossessione di non ritrovarsi nemici a destra e pensando che l’unico che avrebbe pagato il fio dell’operazione del generale sarebbe stato il mal sopportato Salvini. Anche qui senza capire che a passare all’incasso di questa operazione figlia dei tempi bui che viviamo sarebbe stato lo zar moscovita.
Errori la cui gravità non è per nulla attenuata, anzi, dalla condivisione delle sgrammaticature con Elly Schlein. Non necessariamente le stesse di Meloni, ma dello stesso seme. Come il far finta di non vedere che la divergenza sulle scelte internazionale, che in parte divide lo stesso Pd e sicuramente lo contrappone a 5stelle e Avs, è un vulnus per il “campo largo” che o gli farà perdere le elezioni o, in caso contrario, gli impedirà di governare. Errori che il disastroso avvio della campagna per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati fa immaginare vengano ulteriormente ripetuti. Ma della “non riforma della giustizia” avremo modo di parlare più avanti, manca più di un mese all’appuntamento nelle urne.
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.