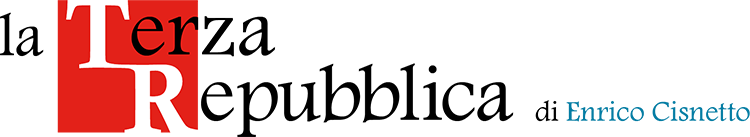La lezione di Xi a Trump
IL VERTICE CINA-USA E L’EUROPA ATTONITA DI FRONTE ALLA GIOSTRA IMPAZZITA DELLA GEOPOLITICA PLANETARIA
di Enrico Cisnetto - 01 novembre 2025
Una giostra, vorticosa. Sulla quale l’Europa deve imparare a salire. Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud – che consacra vari accordi e una tregua nello scontro commerciale Usa-Cina con un dietrofront di Washington dai dazi al 100% – segna l’ennesimo, repentino, cambio di scena in questa incredibile pièce teatrale senza copione che è diventata la geopolitica planetaria. Naturalmente per il presidente americano è stato “un grande successo”, e lui e Xi avranno “un grande rapporto”, tanto da aver già preannunciato che ad aprile andrà in Cina. Mentre per il leader cinese, più misurato e prudente, “essere partner e amici è sia una lezione della storia che una necessità del presente” ma questo non toglie che tra americani e cinesi ci siano “anche attriti”. Una differenza di approccio e di linguaggio che fa capire come da quelle due ore di colloquio sia scaturita solo una tregua tra le due superpotenze rivali, l’ennesima, non certo una pace commerciale né tantomeno geopolitica. Ma questo nulla toglie al fatto che si sia assistito ad un’autentica giravolta da parte di Trump: coerente con la sua “politica della forza” che interseca la tutela degli interessi e le dinamiche del business, per lui, in un batter d’occhio e senza dare alcuna spiegazione, la Cina è passata da nemico numero uno a straordinario interlocutore. Anche a costo di concedere al competitor di guadagnare tempo, e quindi posizioni, nella gara per la supremazia tecnologica planetaria, che Xi nel nuovo Piano quinquennale appena varato conta di conquistare entro il 2030. Basti pensare che soltanto un paio di settimane fa Zhongnanhai (la sede del Partito Comunista cinese e del Governo della Repubblica popolare) brandiva l’arma delle terre rare e la Casa Bianca aveva minacciato dazi al 100% a partire da novembre.
E tutto questo senza neppure sapere, da parte americana, se avrà esito il vero scopo di quell’incontro in terra coreana, e cioè cercare la sponda cinese per far pressione sul Cremlino nel tentativo di arrivare ad una soluzione del conflitto in Ucraina, quella che finora Trump non è riuscito a trovare (o non ha voluto). Dopo il flop del vertice con Putin in Alaska, e dopo lo stridore tra la fanfaronaggine con cui si è annunciata al mondo la “pace eterna” a Gaza e i limiti evidenti di quella fragile tregua già violata, Trump ha disperatamente bisogno di marcare un punto sul fronte ucraino. Ma Xi ha alcune ragioni per usare la tanto esaltata “amicizia senza limiti” tra Mosca e Pechino per smuovere il Cremlino dalla posizione di guerra ad oltranza – peraltro ancora ostentata dall’annuncio di Putin, fatto indossando simbolicamente l’uniforme militare, di una nuova arma russa, il missile Burevestnik, così potente da essere definito “arma invincibile” – ma ne ha almeno altrettante per fare l’esatto contrario (si veda la War Room di martedì 28 ottobre, qui il link). Nell’incertezza, io “andreottianamente” (a pensar male…) tendo a credere che Xi Jinping abbia usato le sue doti di illusionista facendo credere, ma solo credere, a Trump che piegherà Putin ai suoi voleri, ma che di fatto manterrà il sostegno economico e le forniture militari alla Russia e non chiederà a Kim Jong-un di ritirare la presenza dei militari nordcoreani al fronte ucraino. Allo stesso tempo, sono convinto che il leader cinese – in cambio di poco e niente: nessuna restrizione, ma solo per un anno, alla vendita di terre rare, e ripresa dell’import di semi di soia dagli Usa, ma non oltre una certa quantità – abbia incassato la promessa che l’America girerà la testa dall’altra parte quando Pechino deciderà di mettere le mani su Taiwan. Come testimonia il fatto che il governo statunitense ha impedito al presidente taiwanese Lai Ching-te di fare scalo a New York durante un suo viaggio, dimenticandosi la storica protezione americana nei confronti dell’isola del Pacifico e trascurando che Taiwan è la capitale dell’intelligenza artificiale visto che lì si produce la quasi totalità dei microchip avanzati al mondo, e più della metà degli altri. Vedremo presto se, pur avendo fatto peccato, ci ho azzeccato.
Comunque, resta il fatto che Xi si è potuto permettere di impartire a Trump una vera e propria lezione: secondo una ricostruzione del New York Times, gli avrebbe spiegato che “le recenti svolte e i cambiamenti generati dalla guerra commerciale avrebbero dovuto essere istruttivi per entrambi, inducendoli a concentrarsi sui benefici a lungo termine della cooperazione, invece di cadere in un ciclo vizioso di ritorsioni reciproche”. Così, dopo aver concesso a Putin la riabilitazione internazionale, ora ha regalato a Xi il ruolo di leader planetario saggio e conciliante e alla Cina quello di superpotenza che comanda come e per certi versi anche più degli Stati Uniti, e usando il guanto di velluto.
Tutto questo dimostra, ove mai ce ne fosse bisogno, che il paesaggio geopolitico sta cambiando con una rapidità da togliere il fiato. E tocca, more solito, dover constatare che l’Europa – intesa come continente culla di libertà, democrazia e benessere diffuso, prima ancora che come Unione europea – assiste da semplice spettatore, inerme e immobile, a questi rivolgimenti, senza neppure esserne pienamente consapevole, figuriamoci partecipe. Per esempio, sul fronte della guerra russo-ucraina, spera che Xi faccia sul serio e le tolga le castagne dal fuoco, visto che fatica ad aiutare Zelensky senza il sostegno di Trump. Ma intanto deve prendere atto che la Casa Bianca ha informato in sede Nato di aver ritirato con effetto immediato – anche se sulla carta il Congresso potrebbe modificare la decisione – un migliaio di soldati americani dalla Romania e che altri saranno richiamati da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Gli Stati Uniti si sono affrettati a ridimensionare la vicenda, sostenendo che non è la premessa di un ritiro dall’Europa. In realtà, il disimpegno militare americano in Europa era già iniziato con Obama e Biden – noi ignavi – e ora è opportuno mettere in conto che Trump lo accelererà. Dunque, l’Europa, che aveva totalmente disinvestito nella difesa, deve prenderne atto e si deve attrezzare a tutelarsi da sola. Cominciando a capire che sostenere l’Ucraina e difendere il fianco orientale del Vecchio Continente (circa 3mila km) è un unico dossier.
Allo stesso tempo, sul fronte commerciale, essersi beccata prima i dazi di Trump e ora la decisione cinese di introdurre restrizioni all’import di terre rare (di cui la Cina controlla il 90% del mercato), con annessi guai all’industria che necessita di quei metalli, per l’Europa non è solo un danno economico, ma anche e prima di tutto strategico. Significa, da un lato, non aver saputo individuare il modo giusto per fronteggiare Trump – la posizione europea si è rivelata troppo morbida, al contrario di quella dei cinesi, che hanno dimostrato di saper ribattere colpo su colpo – mostrando una pericolosa irrilevanza politica, e dall’altro, significa non aver risolto i dubbi circa il tipo di rapporti che s’intendono tenere con Pechino, divisi tra chi teme l’invasione cinese e vuole mostrarsi prono a Trump e chi invece individua nella Cina e nel suo enorme mercato un fronte da cui non si può prescindere nel quadro delle variabili geopolitiche impazzite. Il risultato è che, come ha titolato il Financial Times qualche giorno fa, l’Europa è la “grande sconfitta” nella guerra tra Stati Uniti e Cina sulle materie prime critiche, fondamentali per lo sviluppo futuro.
Il fatto è che oggi l’Europa parla una lingua diversa da quella dei principali attori planetari (Stati Uniti, Russia, Cina, India), tanto sulle questioni politiche e militari, quanto su quelle economiche. Non si tratta di adeguarsi – anzi, considerato che si tratta di autocrazie o, nel caso degli Usa, di democrazie che si stanno perdendo – ma di prendere atto che lo scenario è cambiato e che questo cambiamento, che produce il passaggio da un’era ad un’altra, richiede una visione e una progettualità che non le consente di limitarsi ad essere, come spiega bene il professor Emilio Barucci, “il continente delle posizioni di principio, se va bene a difesa dei valori fondanti della nostra civiltà, se va male per difendere rendite di posizione o per assecondare istanze particolari disgreganti che portano nei fatti all’inazione”. I problemi dell’Europa li conosciamo: mancanza di un governo continentale, governance comunitaria frammentata, spinte nazionaliste e populiste, leadership non all’altezza della situazione, economie mature poco inclini all’innovazione. E conosciamo anche i rimedi, a cominciare da quelli che Mario Draghi continua a ricordarci. Solo che per essere attivati richiedono due cose: la consapevolezza che non c’è più tempo da perdere, e la conseguente assunzione di responsabilità di procedere verso un doppio obiettivo. Da un lato avviare il processo di integrazione che deve portare agli Stati Uniti d’Europa, sapendo però che i tempi saranno necessariamente lunghi; dall’altro, marciare, in questo caso molto più speditamente, verso la creazione di “un’area europeo-occidentale” che abbia alla base l’attuale “coalizione dei volenterosi”, ma che venga istituzionalizzata, andando cioè oltre il mero patto di consultazione, in modo che ciascun paese formalizzi la propria adesione prendendo impegni vincolanti. Si tratta di qualcosa di molto impegnativo, per certi versi forse anche troppo, ma che appare appena sufficiente se lo si confronta con la velocità della luce con cui il mondo riscrive la geopolitica, le sue dinamiche e le sue regole.
In questo quadro, è fondamentale che in ciascun paese i cittadini pretendano dai rispettivi sistemi politici risposte inequivoche su questioni epocali come queste, e li misurino di conseguenza. A cominciare da noi italiani. Per esempio, non possiamo non dirci che Giorgia Meloni ha commesso nel giro di pochi giorni due errori strategici da matita blu, e proprio sul terreno, quello delle relazioni internazionali, su cui le vengono riconosciuti apprezzamenti lusinghieri anche da parte di chi non la ama. Il primo errore è essersi opposta all’abolizione dell’unanimità nell’Unione Europea (“non intendo proporre una riforma dei trattati per arrivare al voto a maggioranza”), sostenendo che mantenere quel principio – che, ricordiamolo, di fatto si traduce in un diritto di veto per qualunque dei 27 paesi Ue – sia essenziale per tutelare gli interessi nazionali. Il secondo errore è aver concesso al primo ministro Viktor Orban, a Roma per una visita al Papa, un vertice formale a palazzo Chigi, con tanto di onori militari. Anche perché il principale fruitore del diritto di veto a Bruxelles, che non a caso ha poi fatto visita a Salvini, ha ricambiato dichiarando senza mezzi termini che “l’Unione Europea non conta nulla” e che “le sanzioni a Mosca sono un errore”. Procurando alla presidente del Consiglio non solo un forte imbarazzo, ma anche e soprattutto infliggendole una grave delegittimazione. Il fatto è che Orban, d’intesa con Putin, si comporta da agente del caos nell’Unione Europea, e come tale lavora alla creazione di un blocco anti Kiev, che il presidente magiaro ha avuto la faccia tosta di definire “fronte pacifista”. Ribattezzato “Visegrad 3” – ne fanno parte il capo del governo slovacco Robert Fico e il nazionalista Andrej Babis, fresco vincitore delle elezioni in Repubblica Ceca – e nato per fare la sponda alla guerra ibrida che la Russia conduce all’Europa, consente a Orban di assumere la leadership del sovranismo continentale e di ergersi ad unico mediatore tra Putin e Trump. Con ciò togliendo spazio a quella politica di “equidistanza ambigua” che Meloni si è ritagliata, stando più vicina all’Europa (in verità alla sola Ursula von der Leyen) di quanto si potesse temere e nello stesso tempo più vicina a Trump di quanto sarebbe opportuno. Un gioco, quello, che si può fare fintanto che l’Europa resta ferma, attonita. Ma che perde di significato laddove il Vecchio Continente si decida a mettersi in proprio, salendo con coraggio sulla giostra impazzita della geopolitica. Per Meloni, se lo capisce ed è disposta a forzare la sua natura fino in fondo e senza più ambiguità, può essere una grande opportunità. Tanto più dopo lo sgambetto di Orban. Per l’Italia, Meloni o meno, è scegliere il futuro nell’alternativa a condannarsi al passato. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.